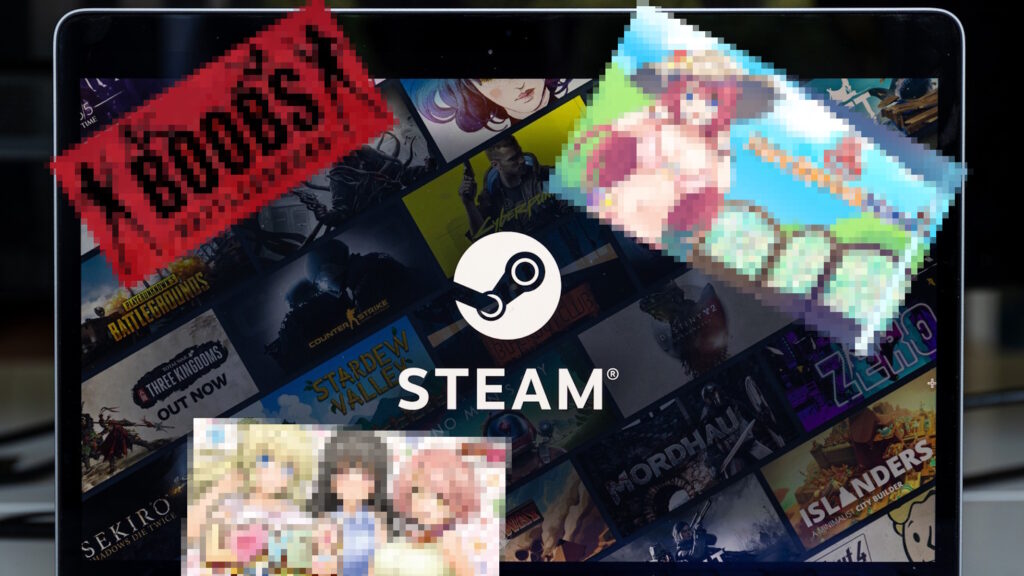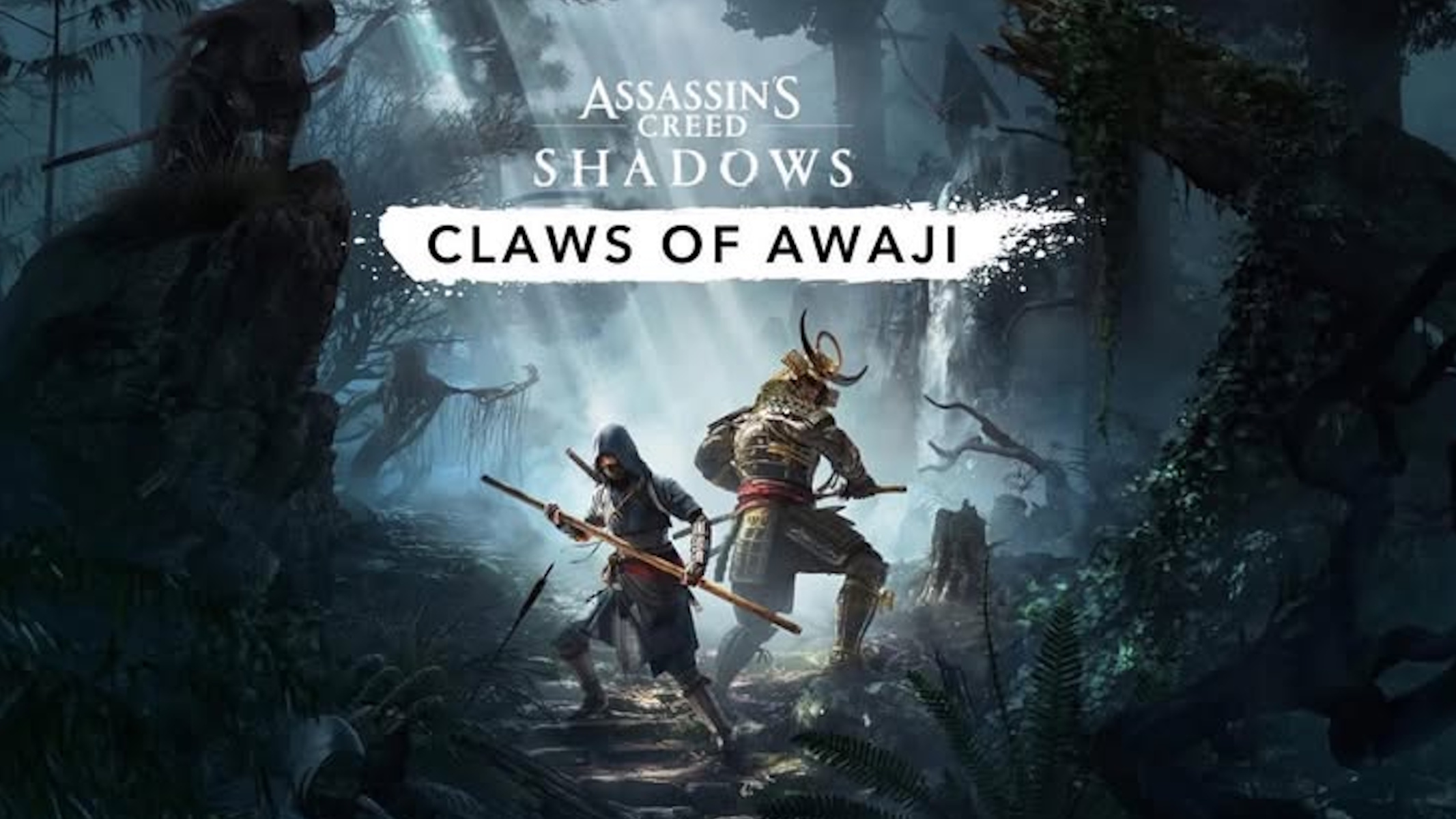Un cambiamento apparentemente tecnico nel regolamento di Steam ha acceso una discussione ben più ampia e problematica: chi decide cosa può essere venduto su una piattaforma digitale? Con una formula vaga che fa riferimento ai “contenuti che possano violare le regole dei processori di pagamento”, Valve ha dato il via alla rimozione di centinaia di giochi a sfondo sessuale. La decisione non è nata nel vuoto, ma come risposta diretta a una campagna portata avanti da Collective Shout, un gruppo australiano noto per le sue posizioni anti-pornografia e per una lunga storia di attivismo culturale.
Il gruppo, fondato da Melinda Tankard Reist, ha fatto pressione sui giganti dei pagamenti digitali come Visa, Mastercard, PayPal, affinché interrompessero i legami con piattaforme che ospitano contenuti giudicati inaccettabili, come Steam e itch.io. La loro campagna ha preso slancio il 7 luglio, con email e telefonate ai circuiti di pagamento, seguita da una lettera aperta. Pochi giorni dopo, il 15 luglio, Steam ha iniziato a rimuovere decine di giochi, confermando poi che la decisione era legata proprio a quelle pressioni.
L’impatto è stato immediato, ma anche confuso. I titoli rimossi secondo SteamDB sarebbero superiori ai 450 di numero, tra giochi completi, DLC e demo. Un numero inferiore rispetto ai “centinaia di giochi di stupro, incesto e abuso di minori” denunciati da Collective Shout. Nonostante ciò, l’organizzazione ha celebrato la “vittoria”, promettendo nuove azioni e insistendo per la rimozione di altri titoli che ritiene ancora presenti. Le dichiarazioni della fondatrice, che accusa i giocatori di essere “pedofili con il cervello marcio dalla pornografia“, hanno sollevato critiche anche da parte di chi condivide alcune preoccupazioni etiche, ma respinge questa retorica estrema.

Libertà d’espressione e censura economica: le community di Steam e itch.io combattono
Al di là del caso specifico, la questione tocca un nodo più profondo. Il potere dei processori di pagamento si sta affermando come una nuova forma di censura, capace di aggirare dibattiti pubblici, leggi nazionali e discussioni culturali. A differenza di un governo, le società come Visa e Mastercard non sono tenute a spiegare o giustificare le loro decisioni, eppure possiedono un controllo capillare sull’accesso economico alla rete. In questo senso, la loro influenza va ben oltre la finanza, diventando un vero strumento di modellazione culturale. Lo stesso è avvenuto su piattaforme come Pixiv, Patreon, Gumroad e DLSite, tutte colpite da imposizioni simili.
Il game designer Yoko Taro ha definito la situazione “pericolosa a un livello completamente nuovo“, denunciando il potere di questi attori privati di limitare contenuti perfettamente legali secondo le leggi locali, in nome di una moralità aziendale che non è né neutra né democratica. Nel frattempo, i media faticano a raccontare la storia in modo approfondito. Due articoli della giornalista Ana Valens per Waypoint, che documentavano il ruolo di Collective Shout nella vicenda, sono stati rimossi dalla casa madre Savage Ventures, portando alle dimissioni di Valens, rese pubbliche, e altri due autori in segno di protesta. Questo silenzio mediatico è un altro segnale d’allarme, che aggiunge al tema della censura anche quello dell’autocensura editoriale.
Steam e itch.io si trovano così in una posizione scomoda, stretti tra la necessità di garantire l’accesso economico alla sua piattaforma e il desiderio, almeno apparente, di non diventare terreno fertile per contenuti realmente problematici. Ma la questione resta: chi stabilisce cosa è “problematico”? E soprattutto, con quale mandato?
La comunità dei giocatori non è rimasta inerte. Una petizione lanciata su Change.org ha rapidamente guadagnato oltre 30.000 firme, esortando Valve a rivedere le sue politiche. Le quattro richieste chiave della petizione mirano a porre fine alla censura di contenuti legali per soli adulti, proteggere la libertà creativa degli sviluppatori, aumentare la trasparenza delle piattaforme e limitare l’influenza di gruppi attivisti come Collective Shout, esplicitamente chiamato in causa. Dunque la battaglia ideologica prosegue, tra chi chiede maggiore controllo sui contenuti e chi difende la libertà creativa in tutte le sue forme. Con i processori di pagamento sempre più determinanti nella definizione delle regole non scritte del web, la partita sembra tutt’altro che chiusa.